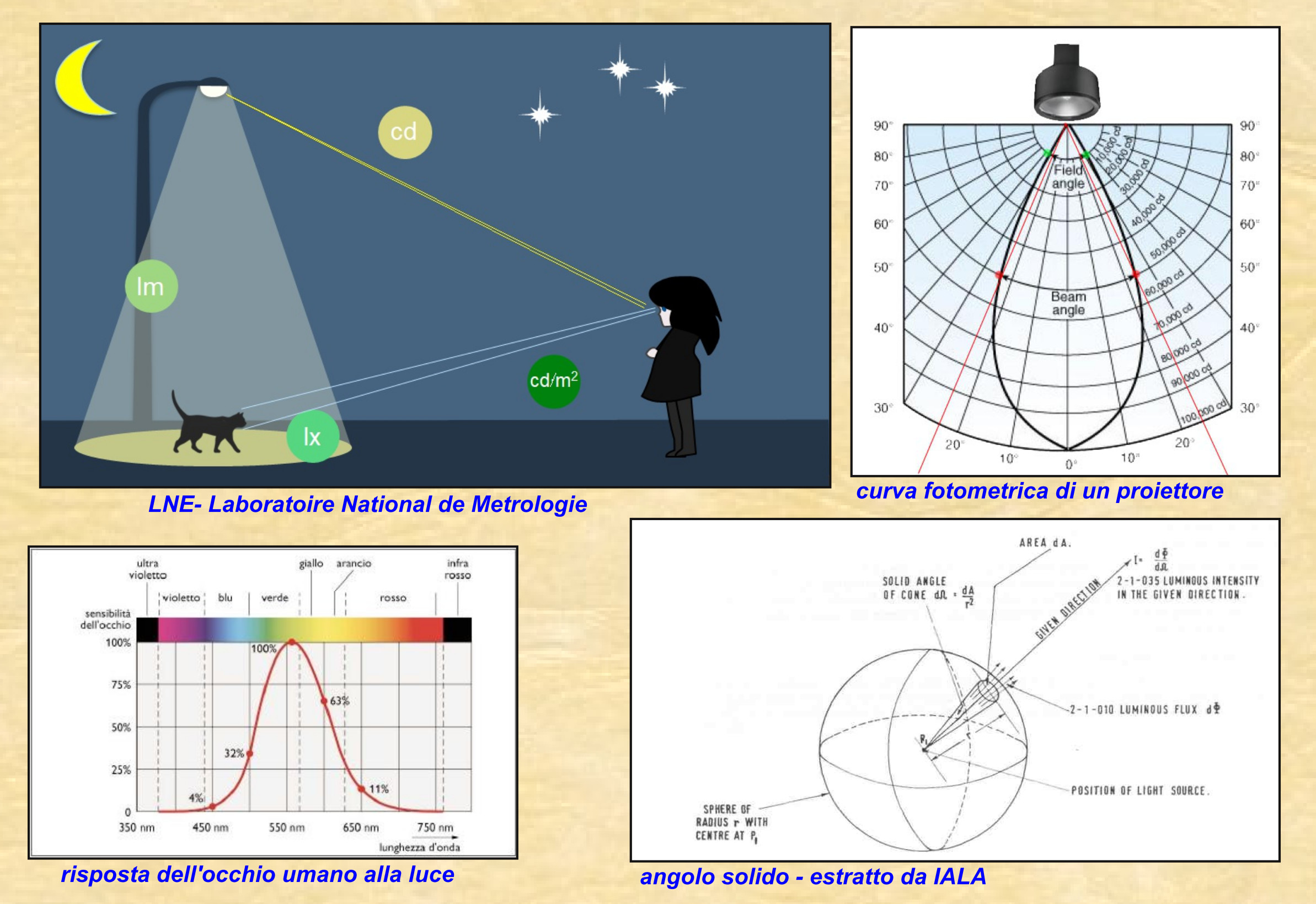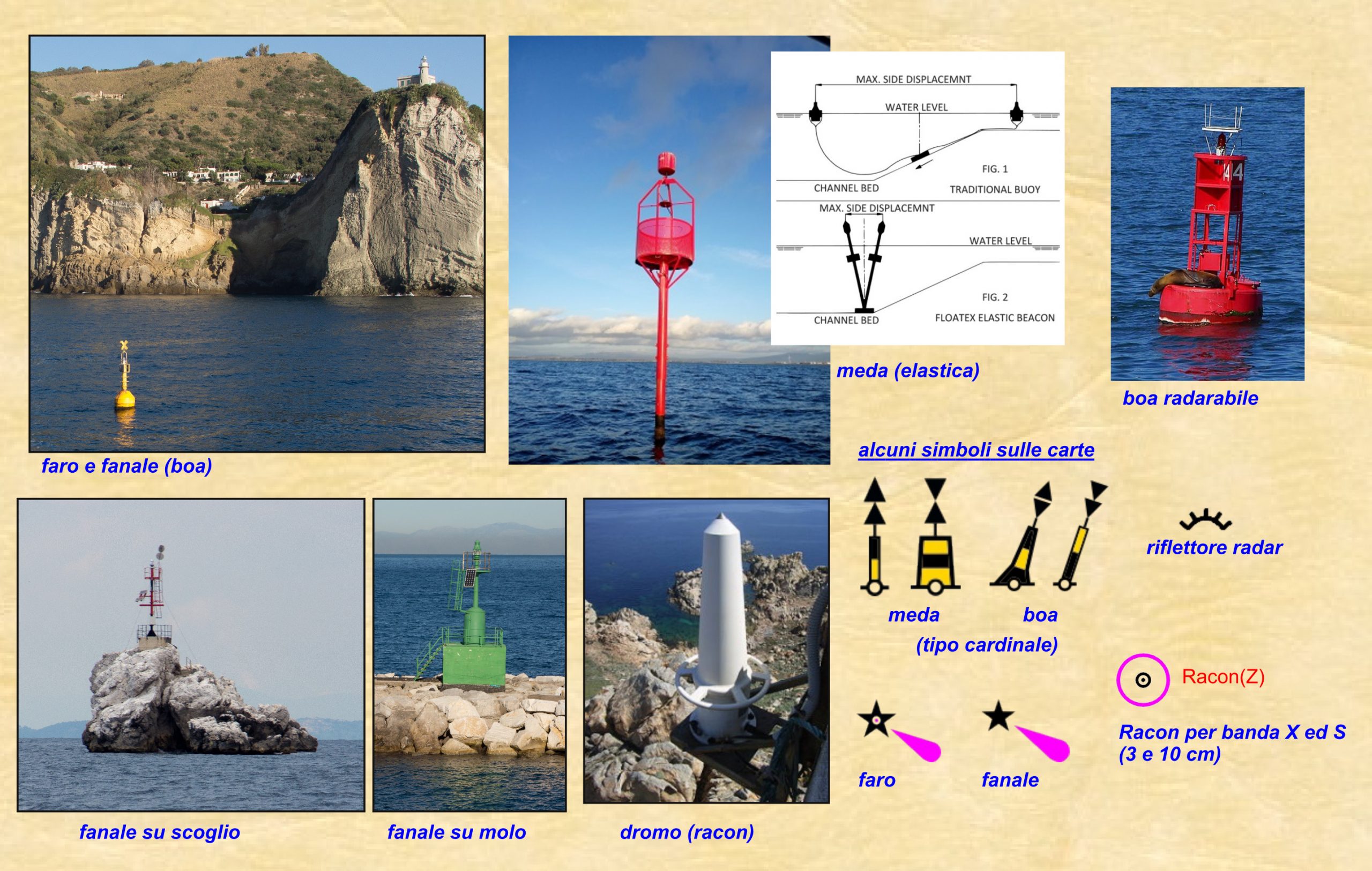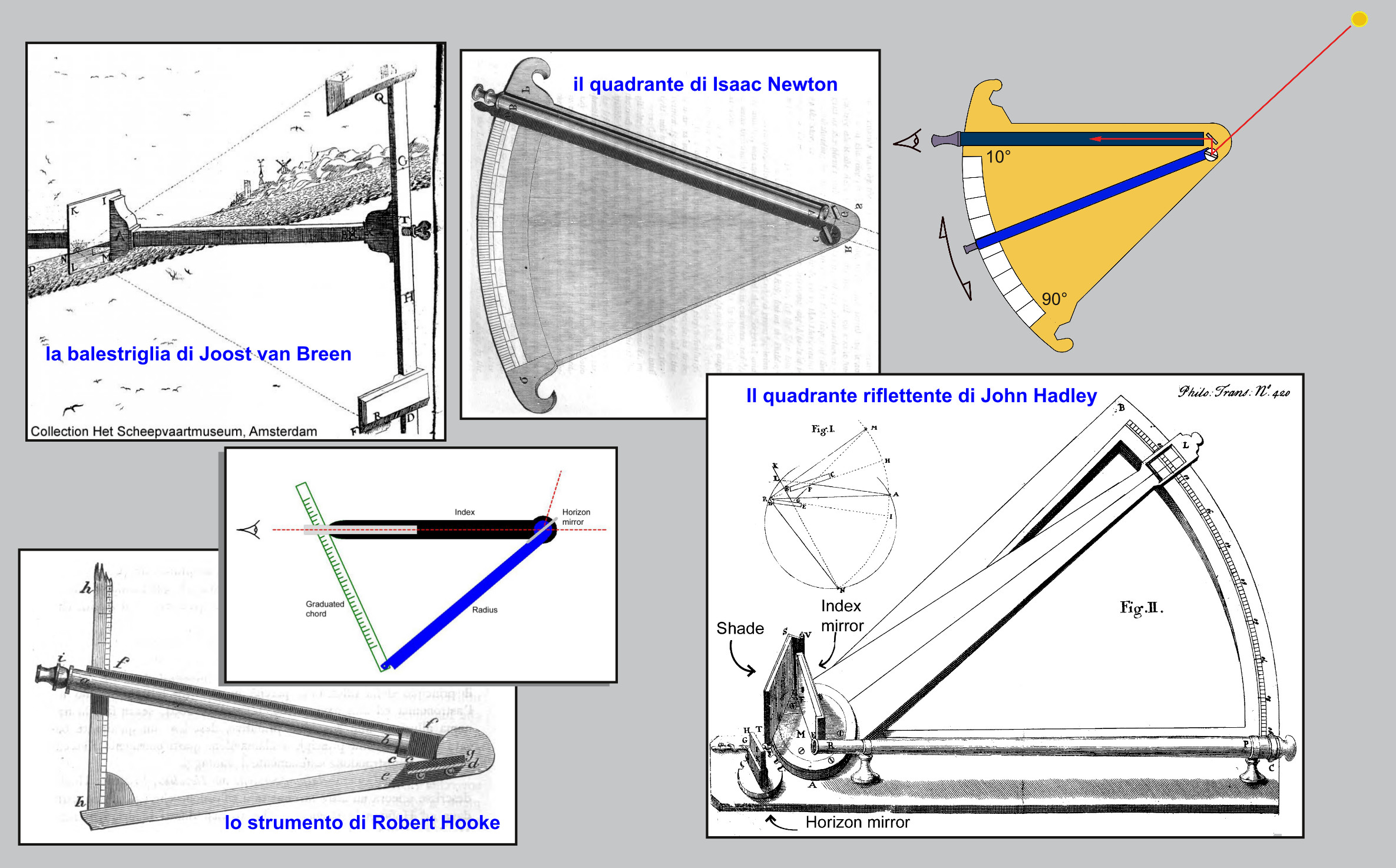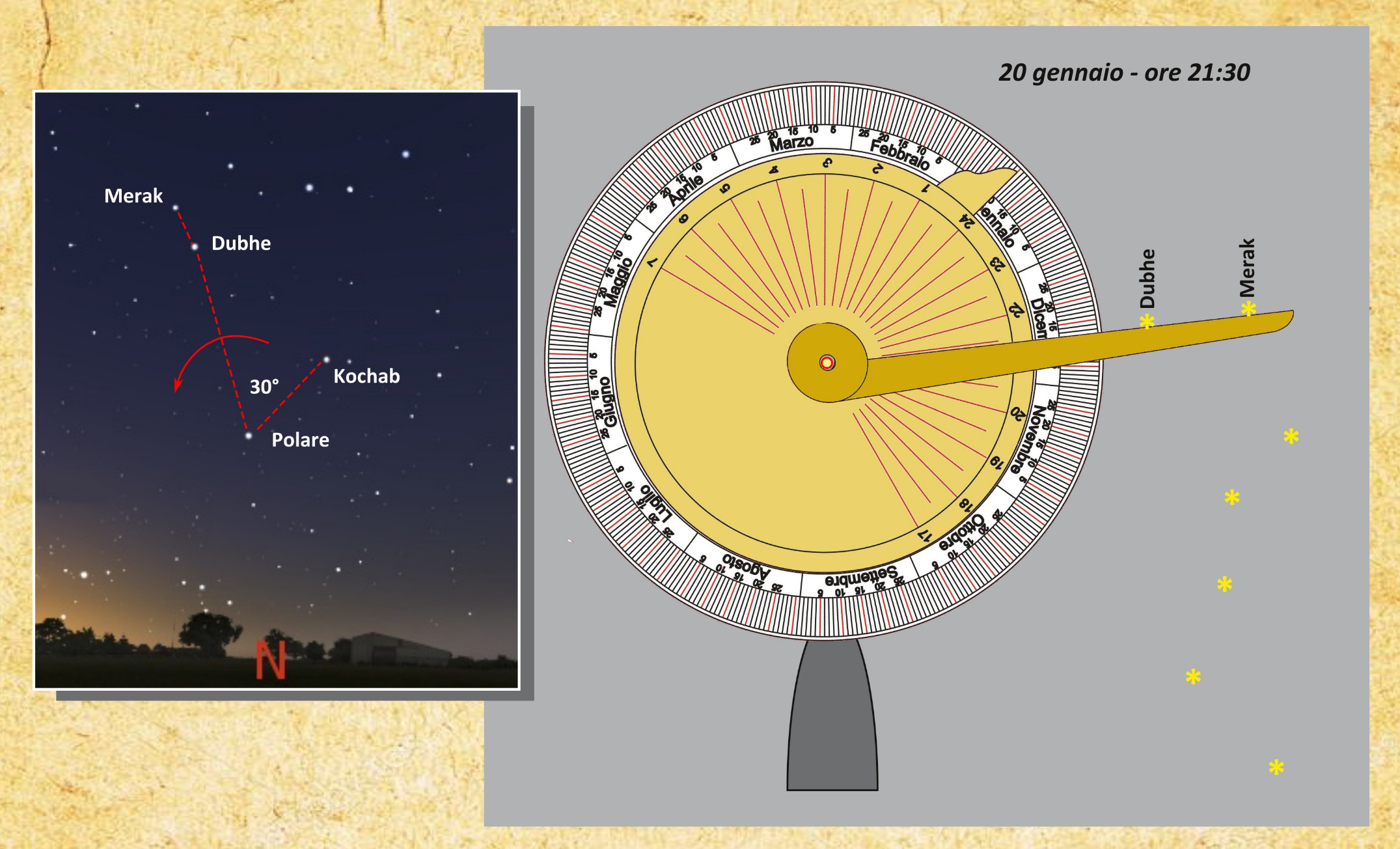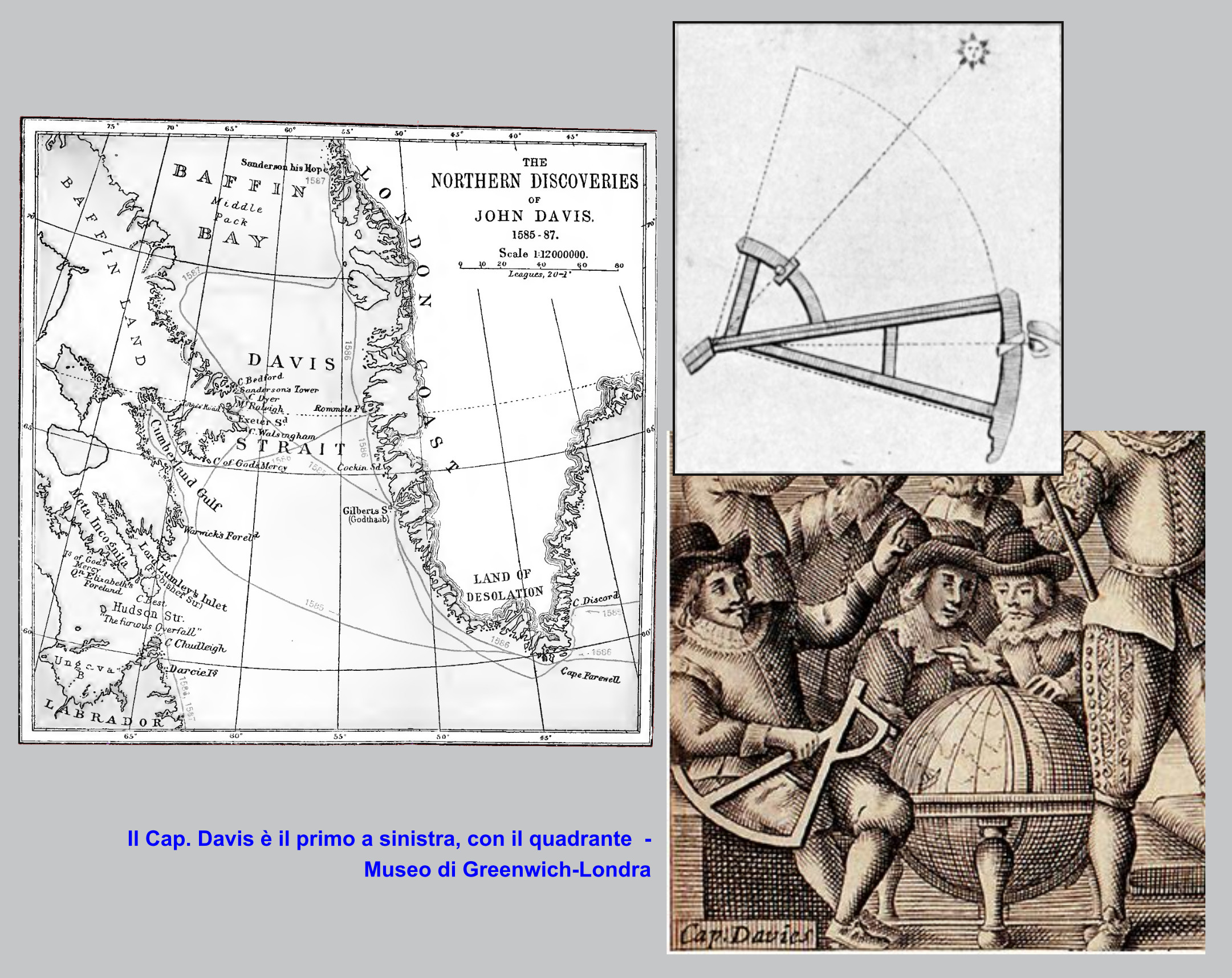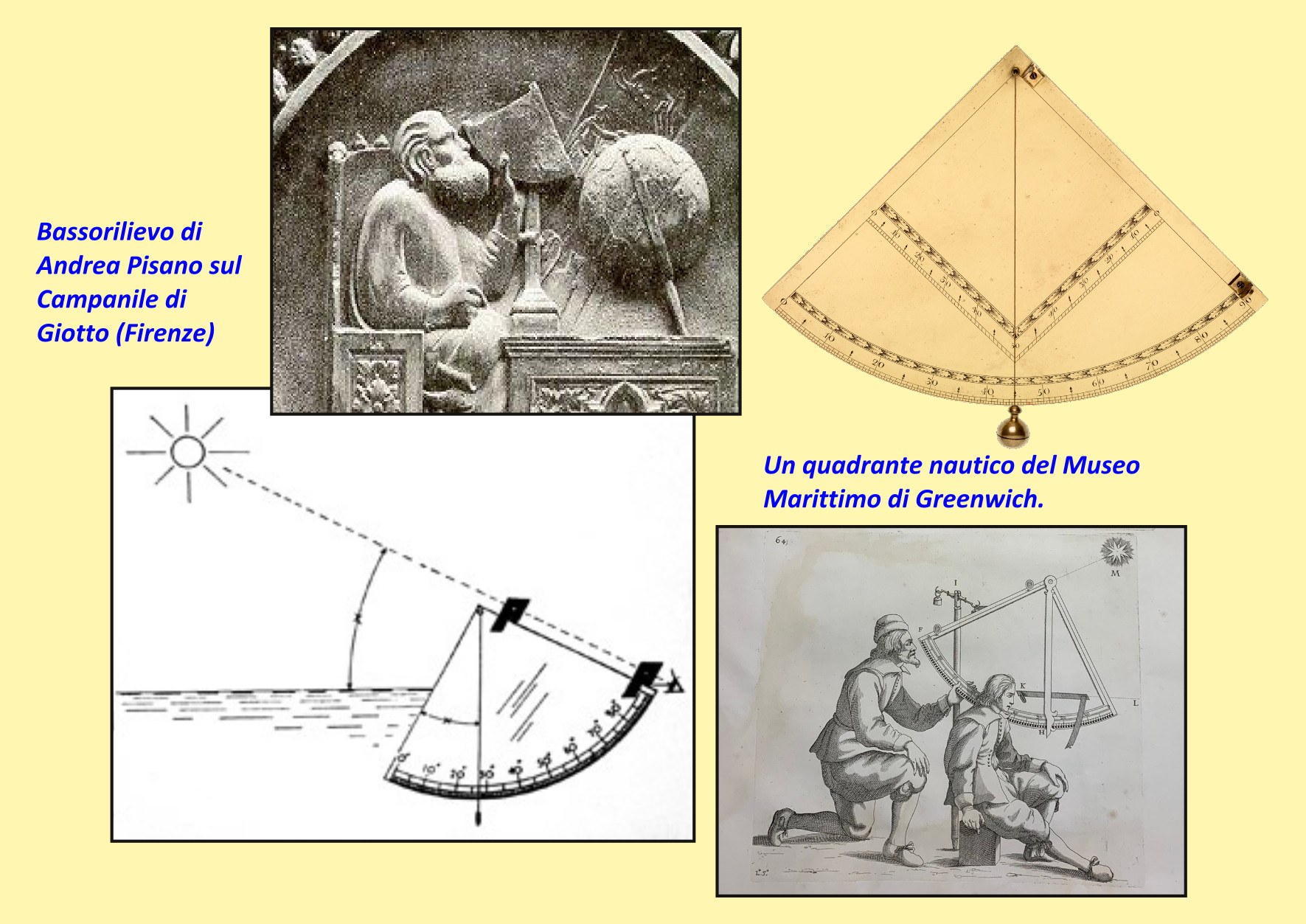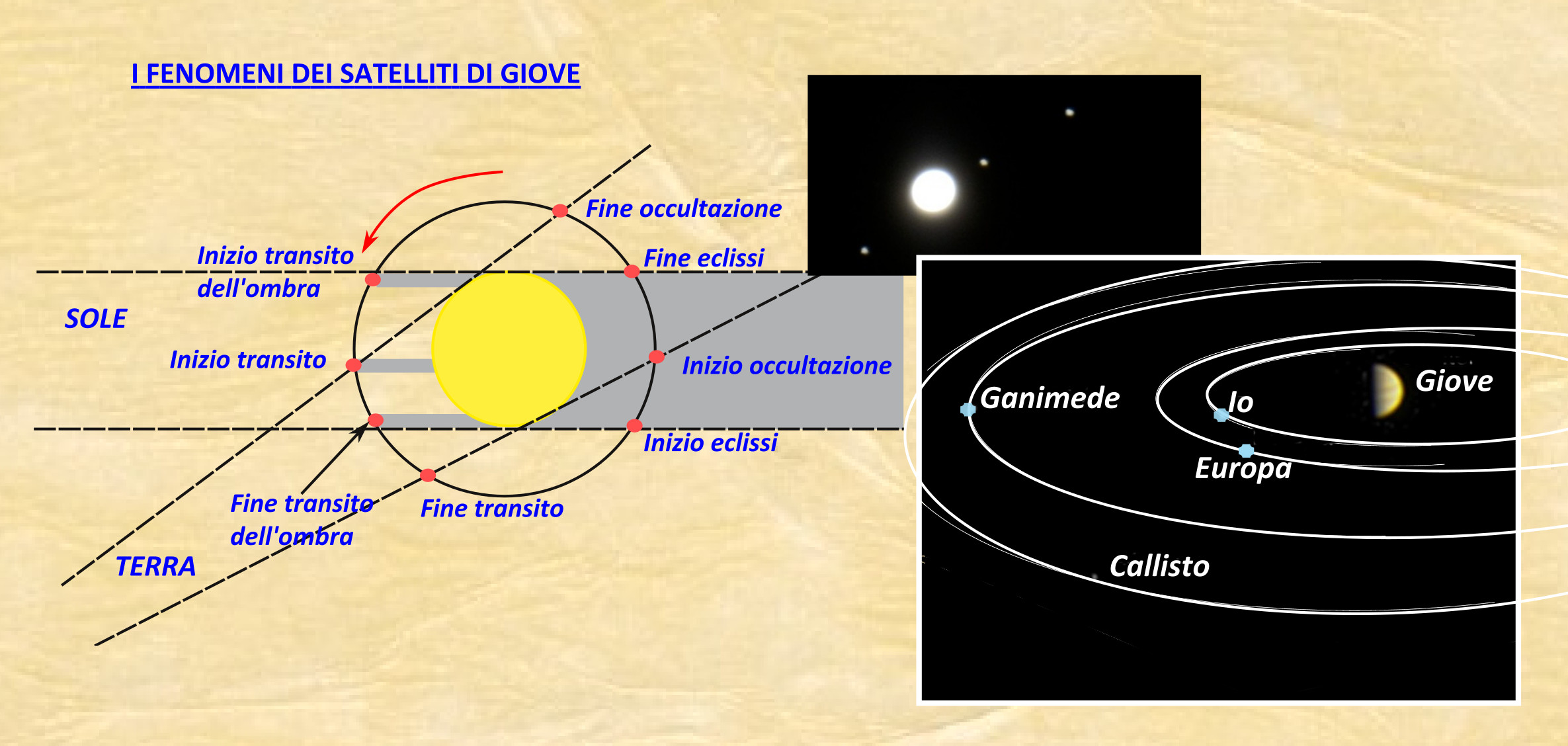Diverse sono le grandezze fisiche utilizzate in fotometria, quella parte della fisica che si occupa di misurare le caratteristiche di un fascio luminoso e dei suoi effetti sull’occhio umano.
flusso
luminoso, (luminous flux) l’energia luminosa E emessa
tutt’intorno da una sorgente luminosa primaria o secondaria (che
riflette la luce proveniente da una sorgente primaria) nell’unità di
tempo, la cui grandezza fisica è il lumen (simbolo lm).
Come un flusso idrico in una condotta, anche il flusso luminoso è
sempre lo stesso, ad 1 cm, ad 1m ad 1 km, come è sempre la stessa la
portata d’acqua in una tubazione a qualunque distanza dalla pompa, a
meno di perdite.
Una lampada a incandescenza quando è accesa
assorbe una potenza elettrica espressa in watt che in piccola parte
si trasforma in flusso luminoso, cioè in potenza visibile, mentre
buona parte si converte in potenza nell’infrarosso che è invece una
potenza non visibile, termica. Il rapporto lumen/watt rappresenta
quindi l’efficienza della lampada, il suo rendimento luminoso, cioè
quanto della potenza assorbita elettrica si trasforma in potenza
luminosa.
illuminamento,
(illuminance)
quantitativo di flusso
luminoso per ogni metro quadrato di superficie esposta, indicativo
dell’effetto, percepito dalla nostra vista, prodotto
da una
sorgente di luce sulla superficie degli oggetti che ci circondano. La
grandezza fisica corrispondente è il lux
(simbolo lx)
lux = lumen/m2.
Così
un ufficio luminoso ha un illuminamento di 400 lx; la luna piena
produce un illuminamento di 0,5 lx; per
le vie di uscita è norma un illuminamento minimo di 5 lx.
L’illuminamento è
funzione inversa del quadrato della distanza, quindi
una stessa fonte luminosa produce lux diversi su superfici a diverse
distanze ed anche a distanze uguali da come il flusso si distribuisce
nello spazio.
intensità
luminosa, (luminous intensity) la quantità di
energia emessa da una sorgente luminosa (flusso luminoso) nell’unità
di tempo e in una data direzione e in un ben definito angolo solido
Ω, misurato
in steradianti (simbolo sr).
La grandezza utilizzata è la
candela
(simbolo cd)
che in origine corrispondeva
all’intensità luminosa proprio
di una candela:
cd = lm/sr.
In generale una
sorgente luminosa non irradia lo stesso flusso luminoso in tutte le
direzioni: una lampadina
a incandescenza o una
fluorescente sono sorgenti
che diffondono la luce in
maniera più uniforme
tutt’intorno (a meno di zone d’ombra dovute
a schermi o altro). Per
esse si impiega il lumen,
ad esempio nel
confrontare
due lampadine
diverse. Per un
corpo illuminante, dalla lampada da scrivania a una
piantana, da una lampada a incasso a un faro, le
valutazioni luminose vengono fatte attraverso
le
curve
fotometriche, rappresentative
della distribuzione spaziale
della luce emessa, che
riportano le
intensità luminose (espresse
in candele) per ciascun
angolo direttivo.
Luminanza, (luminance) o radianza luminosa di una sorgente, corrisponde alla sensazione di luminosità che si riceve da una sorgente luminosa primaria o, per riflessione, da una sorgente secondaria. L’unità di misura è la candela/metro quadro (cd/m²)
Note:
–
L’angolo solido
rappresenta la porzione di spazio tridimensionale tra il vertice di
un solido (un cono o più in generale una piramide), in
cui è posta la sorgente luminosa puntiforme,
ed una superficie A distante
r dal vertice. Si misura in steradianti (sr) e vale
Ω =
A/r2
Una sfera completa ha
un valore di angolo solido = 4πr2/r2
= 4π =
12,5664 sr
(dove
4πr2 è
la superficie di una sfera)
1 sr è un cono di area = r2
.. Più
in generale un cono con un
angolo al vertice α ha un
valore di steradianti di
2π[1-cos
(α /2)]. Lo steradiante è
analogo al
radiante che quantifica gli angoli planari.
– la candela è definita (dal 1979) come l’intensità luminosa in una data direzione di una sorgente che emette radiazione monocromatica alla frequenza di 540×1012 Hz (lunghezza d’onda 555 nanometri) con intensità radiante in quella direzione di valore pari a 1/683 watt in un angolo solido di 1 steradiante, ovvero 0,001464 W/sr.
Tale definizione fa riferimento ad una precisa frequenza in quanto l’occhio umano ha una diversa risposta alla luce: la luce verde/gialla (intorno ai 550 nanometri) stimola maggiormente l’occhio rispetto alla luce blu o rossa di pari potenza.
la potenza radiante in watt (si tratta di energia al secondo, quindi flusso luminoso) è indicativa del rendimento di una lampadina a incandescenza (standard) che assorbe 1 w elettrico per fornire una modesta potenza luminosa di 1/683 watt. Il rimanente è calore. Un tempo, fino ai primi anni ’70 del ‘900, era uso nel parlato comune utilizzare la candela come equivalente del watt per le lampadine ad incandescenza. Capitava di sentir dire: il lampadario ha lampadine da 12 candele, equivalente (improprio) di lampadine da 12 watt.